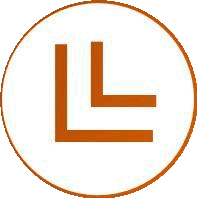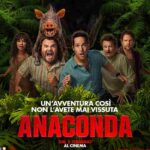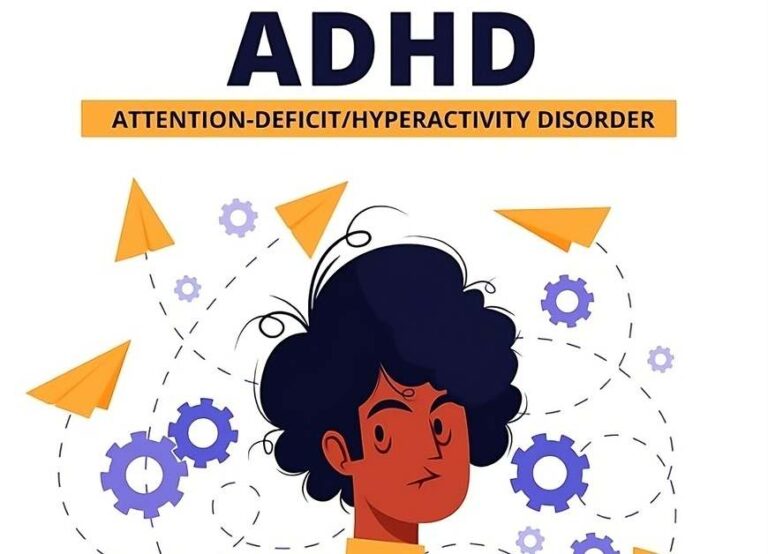Cos’è la Normalità: dove inizia e dove finisce
Nel mondo della psicologia e della psichiatria esiste la necessità di fare “diagnosi”, cioè di trovare i limiti tra normale e patologico. Oggi esistono dei criteri diagnostici certi grazie alla esistenza dei DSM (Manuale dei Disturbi della Salute mentale) che sono arrivati alla loro Quinta stesura affinando sempre di più tutte le classificazioni. Va sottolineato però che esistono delle dipendenze fisiologiche, come per esempio, la reciproca e sana dipendenza del bambino dalla madre o ancora la dipendenza transferale del paziente dall’analista e controtrasferale che è co-costruttiva, dell’analista dal paziente e altre.

Pertanto, si può sostenere che la dipendenza è “fisiologica” quando la sua peculiarità è evolutiva verso l’autonomia, mentre la dipendenza diventa “patologica” quando tende alla ripetizione, cioè al mantenimento che la sottende e per rendere chiara questa diversità basta pensare alla dipendenza per il gioco d’azzardo e per lo shopping compulsivo.
Il confine sottile tra normalità e patologia
Osservando il mondo in cui noi viviamo si scorge che esso è costituito da ripetizioni continue, cioè riproduzioni di stili comportamentali, cognitivi e vissuti affettivi, più precisamente da stili automatici e non evolutivi. Esistono sempre più schemi mentali o modelli preesistenti a cui la generazione “zeta” fa sempre più riferimento in modo esasperante ed esasperato.
Pertanto, con questa realtà come si può definire la normalità? Si può definire in senso statistico come “frequenza”, vale a dire il “normale” è il più frequente, e in senso funzionale quando si parla di salute mentale corrisponde al “soggetto sano”.
Oggi, però la normalità è sempre più caratterizzata dall’uso eccessivo di videogiochi, di televisione, di smartphone con tutti i messaggi compresi, di giochi di ruolo, di cocaina a “basso dosaggio”, di sesso “da consumo”, di cannabinoidi tra i giovanissimi, di anfetaminici in discoteca e tutto ciò fuori esce da un concetto vero di normalità che presuppone una mente sana in quanto questi aspetti patologici entrano in comorbidità con altre patologie come i disturbi depressivi, d’ansia e i disturbi psicotici, tutti correlati con i “disturbi di personalità”.
Tutto questo si spiega con una normalità profondamente patologica, in cui impera l’inadeguatezza di bisogni non appagati, con un vuoto di tipo autistico che distrugge la possibilità di relazioni interpersonali ad ogni livello.
A questo punto, ecco l’incalzare delle dipendenze con difficoltà di empatia, ansia e angoscia, depressione narcisistica che, alla fine, sfocia e si espande a “macchia d’olio” nelle dipendenze da qualsiasi cosa. L’indifferenza a tutto proprio per la mancanza di empatia finisce per esprimersi in una profonda dinamica di annullamento con l’immediato adeguamento a qualsiasi ruolo.
La società contemporanea e le nuove forme di dipendenza
Si costruisce ogni giorno una visione della realtà operativa grazie all’uniformarci alle regole esteriori, cioè ad un qualsiasi tipo di formalità che fa, alla fine, emergere l’alessitimia – l’incapacità di riconoscere le proprie emozioni – e ad esprimerle, in quanto l’altro non entra più in relazione con noi perché il mondo circostante è sempre più virtuale, fittizio, privo della vera dimensione umana che appartiene e dovrebbe continuare ad appartenere all’uomo.
In analogo modo, la depressione narcisistica con i suoi elementi di autostima che si innalzano, accentua i sentimenti di inadeguatezza e di vergogna, in cui il senso di colpa si incapsula proprio nella vergogna.
Non c’è quasi più la possibilità di pensare attraverso l’elaborazione di emozioni e la formazione di legami simbolici e gli stessi modelli, acquisiti, ma non elaborati sono soltanto “modi di fare” ripetuti e costanti, in cui riscrivendo uno stile di vita ci si trova di fronte a quello che Winnicott già nel lontano 1965 descrisse come “falso sé”. L’elemento sempre presente è proprio costituito da una dipendenza da oggetti.
Si è diventati consumatori di oggetti che contengono in sé orientamenti di valore, modelli preordinati della mente, forme di comunicazione virtuali, forme diverse di organizzazione della vita e dei rapporti umani. Si tratta di pensieri-merci, pronti per ogni uso, senza più una personalizzazione né di una diagnosi e neanche di una terapia da parte degli addetti ai lavori.
La perdita dell’identità nell’era dell’intelligenza artificiale
Se si voleva ritornare al pensiero freudiano che vedeva la personalità come una roccia biologica, oggi essa è una struttura porosa che rischia di disintegrarsi nell’ambiente per il suo continuo e incessante divenire virtuale. I messaggi provenienti dall’ambiente stimolano delle risposte “specchio” che mostrandoci come siamo, propongono sia come dovremmo essere che come non dovremmo essere. Appare il tutto come un manuale affettivo, cognitivo e comportamentale che si acquisisce attraverso gli oggetti.
Dove inizia e dove finisce quindi la normalità e l’anormalità? Forse oggi, ognuno, vorrà solo le risposte elaborate dagli algoritmi della’ A.I. (Intelligenza Artificiale)
Dott.ssa Maura Livoli
Psicologo Psicoterapeuta Sessuologo Psicoanalista Consulente tecnico
Roma
- Alcuni dati nel mondo riguardanti le strategie e gli interventi esistenti rispetto alla “Violenza sulle donne”
- Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne: Uniti per Dire Basta
- Intervista di Cristina Speranza al Prof. Fabio Procacciante: Decifrare la Violenza sulle Donne con il suo nuovo saggio “Evoluti per caso”
- Francesca Albanese e il diritto internazionale: la verità ignorata dai media e dal pubblico
- Diritto a stare bene: L’Italia firma per una proposta di…
- A Cecina arriva Pedale Rosso contro la violenza di genere,…
- Inchiesta sul culto del digiuno, farmaci e falsi guru del…
- Resilience Room rivoluziona la Giornata Mondiale della Salute Mentale: nasce…
- “The Bloody Match”: Laika contro la partita Italia–Israele, quando il…
- Nuovi studi shock: la sigaretta elettronica fa male ai polmoni,…
- Intervista di Cristina Speranza al Prof. Fabio Procacciante: Decifrare la…
- Intervista di Brilla a Bryan Ceotto: Comprendere la Disforia di…
- Da Giacomo Urtis a Genny: coraggio, autenticità e la forza…